Le informazioni più richieste:
![]() Iniziative
editoriali
Iniziative
editoriali
Iniziative
di e-learning: E-classics. L'insegnamento del classico nel mondo digitale |
Tutti i testi presentati fanno parte della Collana del Centro Studi "Ricerche".
...
simul ante retroque prospicens
Fuori collana:
Poeti tradotti e traduttori poeti, a cura di I. Dionigi,
Bologna (Patron) 2004, 136 pp.
Di ciascun testo l'indicazione bibliografica è accompagnata dall'immagine del frontespizio. Ogni voce è quindi affiancata da un breve sommario delle sezioni che sono consultabili direttamente on-line e raggiungibili tramite link ipertestuale.
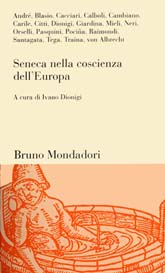 Seneca
nella coscienza dell'Europa. A cura di Ivano Dionigi ("Testi
e pretesti"), Milano (Bruno Mondadori) 1999, XXXII-460 pp., L. 32.000,
€ 16,53. RICERCHE 0.
Seneca
nella coscienza dell'Europa. A cura di Ivano Dionigi ("Testi
e pretesti"), Milano (Bruno Mondadori) 1999, XXXII-460 pp., L. 32.000,
€ 16,53. RICERCHE 0.
Contributi di Ivano Dionigi, Massimo Cacciari, Gualtiero Calboli, Antonio Carile, Alba Maria Orselli, Emilio Pasquini, Marco Santagata, Maria Grazia Blasio, Giancarlo Giardina, Ezio Raimondi, Jean-Marie André, Walter Tega, Alfonso Traina, Michael Von Albrecht, Andrés Pociña, Francesco Citti-Camillo Neri, Giuseppe Cambiano, Paolo Mieli.
Studiosi e intellettuali europei ricostruiscono il percorso storico della crescente influenza del pensiero di Lucio Anneo Seneca nel formarsi della sensibilità e della cultura dell'Occidente.
Questo volume è il risultato di un convegno tenuto nell'aprile del 1999. Clicca qui per accedere al programma
![]() Indice
(formato .html)
Indice
(formato .html)
![]() I
diversi volti di Seneca di Ivano Dionigi (formato .pdf)
I
diversi volti di Seneca di Ivano Dionigi (formato .pdf)
![]() Alcuni
abstract delle relazioni del convegno
Alcuni
abstract delle relazioni del convegno
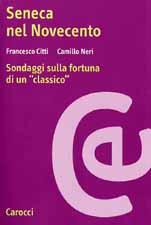 Francesco
Citti-Camillo Neri, Seneca nel Novecento. Sondaggi sulla fortuna di
un "classico", Roma (Carocci) 2001, 271 pp., L. 30.000,
€ 15,49. RICERCHE 1.
Francesco
Citti-Camillo Neri, Seneca nel Novecento. Sondaggi sulla fortuna di
un "classico", Roma (Carocci) 2001, 271 pp., L. 30.000,
€ 15,49. RICERCHE 1.
Giovane provinciale di successo e presto messo al bando, quindi precettore di Nerone, sapiens educato e rilasciato dai vortici del potere, ed infine suicida stoico che mette pace tra sé e le sue parole, Seneca non ha mai lasciato indifferenti i suoi lettori, sempre divisi tra giudizi positivi e negativi: dopo la sostanziale condanna nell'età del romanticismo (con poche eccezioni, tra cui quella di Goethe) che rifiutava il suo stile sentenzioso e il razionalismo interiore giudicandone con durezza le contraddizioni tra principi e stile di vita, nel Novecento si ha la rivalutazione più completa di Seneca, una sua rilettura critica, ma anche il formarsi di uno stereotipo comune, con l'immagine del moralista severo, dell'autore di massime, del saggio sfortunato, del politico ambiguo e tragico. Seneca nel Novecento delinea le vie privilegiate della fortuna nel XX secolo del cordovese, il cui messaggio morale viene ora contaminato con l'etica cristiana e con l'esistenzialismo, ora semplicemente antologizzato o citato per singole sententiae, mentre per il teatro torna ad essere rappresentato o adattato, e ripreso anche nella letteratura grottesca contemporanea. Non viene poi trascurato il Seneca personaggio, nei romanzi e nei drammi storici di ambiente neroniano, nel cinema, nei detti popolari, ed infine il Seneca su Internet.
![]() Indice
(formato .html)
Indice
(formato .html)
![]() Presentazione
di Ivano Dionigi (formato .pdf)
Presentazione
di Ivano Dionigi (formato .pdf)
![]() Premessa.
I molti Seneca del Novecento (formato .pdf)
Premessa.
I molti Seneca del Novecento (formato .pdf)
![]() Capitolo
4. Seneca in Internet (formato .pdf)
Capitolo
4. Seneca in Internet (formato .pdf)
![]() Link
di interesse senecano (formato .html)
Link
di interesse senecano (formato .html)
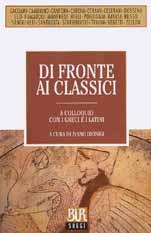 Di
fronte ai classici. A colloquio con i greci e i latini. A cura di
Ivano Dionigi, Milano (BUR) 2002, 271 pp., L. 15.490, € 8,00. RICERCHE
2.
Di
fronte ai classici. A colloquio con i greci e i latini. A cura di
Ivano Dionigi, Milano (BUR) 2002, 271 pp., L. 15.490, € 8,00. RICERCHE
2.
Contributi di Massimo Cacciari, Giuseppe Cambiano, Luciano Canfora, Carlo Carena, Vincenzo Cerami, Remo Ceserani, Gianpaolo Dossena, Umberto Eco, Marc Fumaroli, Valerio M. Manfredi, Paolo Mieli, Giuseppe Pontiggia, Adriano Prosperi, Gianfranco Ravasi, Lucio Russo, Edoardo Sanguineti, Marco Santagata, Jean Starobinski, Alfonso Traina, Mario Vegetti, Paolo Zellini.
Le antiche voci di Atene e Roma parlano ancora ai cittadini delle metropoli del terzo millennio? Cos'hanno in comune Omero, Virgilio, Agostino con la nuova trinità Inglese-Internet-Impresa? I classici greci e latini sono dei compagni di viaggio o un esercito di morti? A queste domande rispondono letterati, biblisti, filosofi, storici, scienziati, critici, scrittori e poeti dei nostri giorni in diverse forme di scrittura: dal saggio all'intervista, dalla riflessione aforistica all'epistola autobiografica, dalla lirica al racconto, dal manifesto teorico alla ricognizione documentaria. A questi maestri e interpreti del nostro tempo i classici si rivelano sia come i garanti della nostra identità linguistica e culturale sia come i testimoni di una irriducibile diversità nei confronti del nostro presente.
![]() Indice
(formato .html)
Indice
(formato .html)
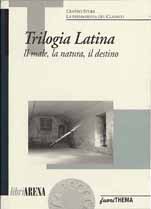 Trilogia
Latina. Il male, la natura, il destino. A cura del Centro Studi "La
permanenza del classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2002,
128 pp., € 2,50. RICERCHE 3.
Trilogia
Latina. Il male, la natura, il destino. A cura del Centro Studi "La
permanenza del classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2002,
128 pp., € 2,50. RICERCHE 3.
La parola dei classici - nella sua irriducibile distanza da noi - è attuale, coinvolgente e anche necessaria in un momento in cui quella dei moderni, affilitti dal "provincialismo di tempo" (Eliot), appare flebile, confusa e inattuale. Una parola da leggere, commentare, accompagnare con musica e immagini. Una parola per tutti. Ed è proprio questo il senso di Trilogia latina, che raccoglie le tre serate organizzate dal Centro Studi "La permanenza del Classico" dell'Università degli Studi di Bologna, in collaborazione con Arena del Sole - Nuova Scena - Teatro Stabile di Bologna, l'8, il 15 e il 22 maggio 2002.
Monica Guerritore legge la Medea e la Fedra di Seneca, roberto Herlitzka il De rerum natura di Lucrezio, Carlo Cecchi l'Eneide di Virgilio; in parallelo Ivano Dionigi parla del problema del male, Douglas R. Hofstadter degli atomi e del cosmo, Massimo Cacciari del destino del vincitore 'sconfitto'; l'accompagnamento musicale scandisce lettura e commento.
Alla domanda "perché i classici?", vi è, tra le tante, una risposta semplice: perché i classici rendono la vita migliore e più ricca, con il loro continuo richiamo alla comprensione, al confronto, alla traduzione. Un piacere, persino un divertimento, che vorremmo trasmettere anche agli altri, soprattutto ai più giovani, il cui destino culturale, morale e civile è legato anche alla possibilità di sentirsi comunità anche col passato.
![]() Consulta
l'indice (formato .html)
Consulta
l'indice (formato .html)
![]() Leggi
il libro in formato *.pdf
(formato stampabile con testo a fronte) o in formato *.doc
oppure scaricalo
(formato .zip) nei due formati
Leggi
il libro in formato *.pdf
(formato stampabile con testo a fronte) o in formato *.doc
oppure scaricalo
(formato .zip) nei due formati
Tre
infiniti. Il divino, l'anima, l'amore. A cura del Centro Studi "La
permanenza del classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2003,
139 pp., € 2,50. RICERCHE 4.
Gerusalemme, Atene e Roma: che cosa hanno in comune con noi? A questa domanda intende rispondere l’iniziativa Tre infiniti. Il divino, l’anima, l’amore, con la lettura e il commento di testi ebraici, greci e latini proposti al pubblico nei giorni 8, 15, 22 maggio 2003 e qui raccolti a cura del Centro Studi "La permanenza del Classico" dell’Università degli Studi di Bologna.
Il divino, l’anima, l’amore: una trinità indecifrabile che reclama la voce, la ricerca, la necessità dell’altro: l’altro (e l’Altro) che in diverse forme è in noi, di fronte a noi, contro di noi. Su questa voce, ricerca e necessità i classici dell’antichità hanno prodotto e codificato testi che resistono al tempo e alle mode. Questi testi, più che lo sfondo, sono la forza antagonista del nostro presente: ci soccorrono non solo nel recuperare la nostra identità linguistica ma anche nel fornire un antidoto etico alla signoria del pensiero unico, impoverito e impoverente. Nell’attesa - e nella speranza - che se ne scrivano altri così evocativi e provocatori.
Maddalena Crippa e Paolo Bonacelli leggono passi di Lucrezio, Manilio, Seneca, Agostino, Niccolò Cusano; Carlo Rivolta mette in scena il Fedone di Platone; Monica Guerritore e Massimiliano Cossati leggono il Cantico dei cantici: in parallelo Ivano Dionigi parla del divino, Massimo Cacciari dell’anima, Gianfranco Ravasi dell’amore.
Sul tema del divino la letteratura latina ci ha trasmesso voci particolarmente significative: tra queste, il materialista e iconoclasta LUCREZIO (I sec. a.C.), gli stoici e spiritualisti MANILIO (I sec. d. C.) e SENECA (4 a.C. - 65 d.C.), l’esploratore dell’interiorità e teologo della grazia AGOSTINO (354-430), il filosofo e fautore del dialogo interreligioso NICCOLÒ CUSANO (1401-1464).
A PLATONE (427-347 a.C.) si deve il Fedone, dialogo che ha segnato in maniera decisiva la riflessione dell’Occidente sull’anima, sulla sua origine e dignità di ente immortale, che dà fondamento etico alle scelte e alla responsabilità dell’individuo.
Insuperato inno all’amore rimane il Cantico dei cantici (attribuito a Salomone, ma di età ellenistica: IV/III sec. a.C.?), che rappresenta l’eterno incontro tra l’uomo e la donna e che - secondo la lettura simbolica tradizionale - scopre nell’eros umano traccia dell’amore infinito di Dio.
![]() Consulta
l'indice (formato .html)
Consulta
l'indice (formato .html)
![]() Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
 Nel
segno della parola. A cura del Centro Studi "La permanenza del
classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2004, 219 pp., €
2,50. RICERCHE 5.
Nel
segno della parola. A cura del Centro Studi "La permanenza del
classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2004, 219 pp., €
2,50. RICERCHE 5.
La parola oggi non ci è amica: inghiottita dalla imperante legge della velocità, essa è ridotta a vocabolo, slogan, merce. Ma se il nostro tempo appartiene ormai ai padroni del linguaggio, noi dobbiamo riappropriarci di parole espropriate: noi dobbiamo tornare a essere cittadini del linguaggio.
Nel segno della parola risuonano le voci degli autori greci, latini, giudaico-cristiani che ci orientano nell’impero retorico del nostro presente, e che il Centro Studi “La permanenza del Classico” dell’Università degli Studi di Bologna offre al pubblico nei giorni 6, 13, 20 maggio e 3 giugno 2004. La parola che strega, che inganna, che offende: ma che sa anche nominare il vero, elevare gli animi, lenire il dolore.
I classici – i nostri contemporanei – possono farci il dono di un nuovo linguaggio: della riconciliazione tra l’eloquenza e la sapienza, tra il dire e il parlare, tra il suono e il significato delle parole. Quello di essere filologi – amici delle parole – non deve essere privilegio di pochi, bensì diritto e impegno di ogni uomo.
Carlo Rivolta interpreta il dibattito fra Simmaco e Ambrogio, Fabrizio
Gifuni e Sonia Bergamasco leggono Teognide, Gorgia, Virgilio, Agostino
e Marziano Capella; a Monica Guerritore e Massimo Popolizio sono affidati
Tucidide, Platone, Cicerone, Fedro e Tacito; a Roberto Herlitzka alcuni
testi fondanti della tradizione giudaico-cristiana. Accanto alle letture,
i commenti di Massimo Cacciari, Daniele Del Giudice, Ivano Dionigi, Umberto
Eco e Gianfranco
Ravasi.
La parola, il potere: nodi della riflessione che attraversa Gerusalemme,
Atene, Roma. Sul tema della tolleranza religiosa si oppongono, sul finire
del IV sec. d.C., la retorica del pagano SIMMACO e quella del cristiano
AMBROGIO. Meraviglie e miraggi della parola descrivono il sofista GORGIA
(V/IV sec. a.C.), il cristiano AGOSTINO (IV/V sec. d.C.), il retore MARZIANO
CAPELLA (V sec. d.C.); la parola eternante del poeta cantano TEOGNIDE
(VI sec. a.C.) e VIRGILIO (I sec. a.C.); la parola liberatrice della filosofia
celebra il materialista LUCREZIO (I
sec. a.C.). Sugli ambigui rapporti fra parola e potere riflettono l’ottimista
CICERONE (I sec. a.C.), i disincantati TUCIDIDE (V sec. a.C.), FEDRO (I
sec. a.C./I sec. d.C.), TACITO (I/II sec.d.C.), l’ironico Platone
(IV sec. a.C.). La parola divina che crea e vivifica, e la parola umana
che la accoglie o la dissipa, sono al centro dell’Antico (GENESI,
SALMO 19) e del Nuovo Testamento (LUCA, GIACOMO, GIOVANNI).
![]() Consulta
l'indice (formato .html)
Consulta
l'indice (formato .html)
![]() Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
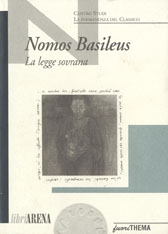 Nomos
Basileus. La legge sovrana. A cura del Centro Studi "La permanenza
del classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2005, 236 pp., €
5,00. RICERCHE 6.
Nomos
Basileus. La legge sovrana. A cura del Centro Studi "La permanenza
del classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2005, 236 pp., €
5,00. RICERCHE 6.
Universale e individuale, assoluta e storica, inafferrabile e quotidiana.
Cosi e la legge; esposta a dilemmi e paradossi, e soprattutto a una domanda:
quale il suo fondamento? Detto altrimenti, con le parole del poeta Pindaro:
come puo essere la "legge sovrana" (nomos basileus)?
Intorno alla sovranita della legge invitano a riflettere gli autori greci,
latini e giudaico-cristiani, che ripropongono all'uomo di oggi le antinomie
che attraversano l'Occidente. Legge positiva e diritto naturale: la legge
si fonda sulla natura o su un patto fra gli uomini? Legge e politica:
la citta si regge sulla legge, ma chi sceglie la legge della citta? Legge
e coscienza: il senso di giustizia si incarna nella legge, o ne eccede
sempre la misura? Legge e Spirito: la legge di Dio si fonda sul rispetto
della lettera o sulla liberta dell´amore?
Siamo di nuovo alla domanda di venticinque secoli fa: "che cos´è
la legge?".
Siamo, soli, in attesa lunga e vana, di fronte a quella porta aperta ma
inaccessibile, a chiedere al guardiano di "entrare nella legge".
Ne colpevoli ne innocenti.
Monica Guerritore, Luca Lazzareschi, Lino Guanciale e Viola Pornaro danno
voce alla tragedia di Antigone. A Giovanni Crippa e a Elisabetta Pozzi
sono affidati alcuni testi capitali della riflessione politica e giuridica
greco-romana. Warner Bentivegna e Sandra Ceccarelli interpretano passi
fondanti della tradizione giudaico-cristiana. Accanto alle letture, i
commenti di Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Gianfranco Ravasi e Gustavo
Zagrebelsky. Infine, Carlo Rivolta fa rivivere l'apologia di Socrate scritta
da Platone.
La sovranita della legge: un enigma che dall'antichita torna a investire
il nostro presente. Il conflitto fra legge pubblica e giustizia soggettiva
e al centro dell'Antigone di SOFOCLE (442 a.C.). Sui fondamenti della
legge si interrogano ANTIFONTE (V sec. a.C.), SENOFONTE (V/IV sec. a.C)
e CICERONE (I sec. a.C.). ERODOTO (V sec. a.C.) mette in scena il dibattito
sulle forme di costituzione, e lo PSEUDO-SENOFONTE analizza spietatamente
la democrazia ateniese. PLATONE (V/IV sec. a.C.) mostra in Socrate un
esempio di strenua fedelta alle leggi, mentre LUCANO (I sec. d.C.) rappresenta
un Cesare che distrugge l'ordine giuridico della Repubblica. Le origini
delle leggi al principio della storia umana sono rappresentate da LUCREZIO
(I sec. a.C.) e da TACITO. Le LEGGI DELLE XII TAVOLE (451 a.C.) danno
principio all'attivita legislativa romana, mentre la riflessione di TERTULLIANO
(II sec. d.C.) ne sottopone la validita ai principi della giustizia e
del progresso culturale. Il rapporto fra legge umana e legge divina, nonche
fra lettera e spirito della legge, e al centro dell?Antico (ESODO, DEUTERONOMIO,
SALMO 119, ISAIA) e del Nuovo Testamento (MATTEO, PAOLO). La difesa di
Socrate scritta da PLATONE, infine, ripropone uno dei piu discussi processi
della storia occidentale.
![]() Consulta
l'indice (formato
.html)
Consulta
l'indice (formato
.html)
![]() Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
 Daniele
Del Giudice, Umberto Eco, Gianfranco Ravasi, Nel segno della parola,
a cura e con un saggio di Ivano Dionigi, Milano (BUR), 2005, 127
pp., € 8,20.
RICERCHE 7.
Daniele
Del Giudice, Umberto Eco, Gianfranco Ravasi, Nel segno della parola,
a cura e con un saggio di Ivano Dionigi, Milano (BUR), 2005, 127
pp., € 8,20.
RICERCHE 7.
"Se i grandi cambiamenti si riconoscono dalle parole, allora l'imperativo è quello di creare un nuovo lessico per nominare questo presente globale, eppure così frantumato, estraneo, eppure così invadente"
Ivano Dionigi
La parola che da arma difensiva e offensiva si riduce a "merce"
(Del Giudice); la parola che si piega a strumento di "prevaricazione",
come dimostrano gli eccessi tragici degli ultimi tempi (Eco); la parola
dell'uomo che si contrappone a quella di Dio e si fa "diabolica",
divenendo veicolo di odio e divisione (Ravasi). Tre autori contemporanei
dialogano con i testi di Gerusalemme, Atene e Roma, riuniti qui in un'antologia
che ripercorre alcuni momenti esemplari della riflessione antica sulla
parola e sul suo rapporto con il potere, dalla Genesi alle Nuvole
di Aristofane alle Confessioni di Sant'Agostino.
Oggi, nel tempo del rinnovato "impero della retorica", la tragedia
è che i padroni del linguaggio mandino in esilio i cittadini della
parola. In questa prospettiva la filologia, l'"amore per la parola",
trascende il significato di disciplina specialistica e si eleva a impegno
morale e civile di ogni uomo.
![]() Consulta
l'indice
(formato .html)
Consulta
l'indice
(formato .html)
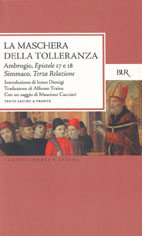 La
maschera della tolleranza, introduzione di I. Dionigi, traduzione
di A. Traina, con un saggio di M. Cacciari, Milano (BUR-Rizzoli) 2006,
151 pp., RICERCHE 8.
La
maschera della tolleranza, introduzione di I. Dionigi, traduzione
di A. Traina, con un saggio di M. Cacciari, Milano (BUR-Rizzoli) 2006,
151 pp., RICERCHE 8.
Non si puo giungere per una sola via al mistero di Dio (Simmaco).
Il solo vero Dio e quello dei Cristiani (Ambrogio).
Nel 384 d.C., alle soglie di un decennio fatale per le sorti del paganesimo,
il prefetto di Roma Simmaco e il vescovo di Milano Ambrogio si affrontano
in merito alla presenza dell'altare della Vittoria nel Senato. Simmaco,
l'uomo della religione tradizionale, invoca pluralismo e tolleranza per
gli dei dell'antica Roma; Ambrogio, l'uomo della nuova fede, nega ogni
possibilita di dialogo e di compromesso tra vecchia e nuova religio, censurando
come segreta volonta di dominio l'appello di Simmaco alla tolleranza.
Una delle prime e piu significative tappe di quel dibattito sulla tolleranza
che impegnera tanta parte del pensiero moderno e contemporaneo e che,
ancora oggi, induce a chiedersi se ci si debba rassegnare alla scelta
tra un altare e un altro e all'impossibilita del dialogo tra chi crede
nel dio noto e chi s'interroga sul dio ignoto.
![]() Consulta
l'indice (formato
.html)
Consulta
l'indice (formato
.html)
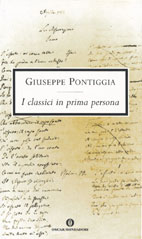 Giuseppe
Pontiggia, I
classici in prima persona, a cura e con un saggio di Ivano
Dionigi, Milano (Mondadori), 2006, 127 pp., € 8,20.
RICERCHE 9.
Giuseppe
Pontiggia, I
classici in prima persona, a cura e con un saggio di Ivano
Dionigi, Milano (Mondadori), 2006, 127 pp., € 8,20.
RICERCHE 9.
I classici in prima persona comprende il testo inedito di un incontro
tenuto da Pontiggia nel novembre 2002 presso l'Universita di Bologna (il
suo ultimo intervento pubblico) e un breve saggio, entrambi dedicati a
uno degli argomenti piu cari allo scrittore: il rapporto con i classici.
A cavallo tra critica filologica e rievocazione autobiografica, i due
scritti, in cui l'autore ripercorre la propria biografia intellettuale
nel segno degli amati scrittori greci e latini, riflettono su alcuni temi
nodali di tutta la produzione saggistica, e non solo, di Pontiggia: il
concetto di "classico", i fantasmi dei Maestri, la funzione
del canone, l'ambiguo connubio tra retorica e politica... Chiude il volume
uno scritto di Ivano Dionigi, che illustra il rapporto di Pontiggia con
gli antichi.
![]() Consulta
l'indice (formato
.html)
Consulta
l'indice (formato
.html)
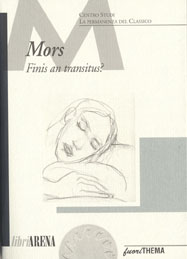 Mors.
Finis an transitus?. A cura del Centro Studi "La permanenza del
classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2006, 224 pp., RICERCHE
10.
Mors.
Finis an transitus?. A cura del Centro Studi "La permanenza del
classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2006, 224 pp., RICERCHE
10.Una lunga riflessione sulla morte attraversa il pensiero antico, nella misura in cui esso non cessa di essere riflessione sull’uomo: il "mortale che dura un giorno" in opposizione agli "dei immortali che vivono per sempre".
Alla domanda "cos'è la morte?", Seneca risponde con la rigida alternativa "o fine o passaggio" (aut finis aut transitus), codificando due concezioni contrapposte: quella materialistica, per cui la morte è finis, e quella spiritualistica, per cui la morte è transitus.
La riflessione classica e giudaico-cristiana, oltre a conoscere molteplici spiegazioni della morte, elabora anche vie d'uscita e strategie di superamento da proiettare non solo nell'aldilà ma anche nell'aldiquà.
Piu che un inizio e una fine, un prima e un poi, un qui e un altrove, vita e morte appaiono – tanto agli antichi quanto ai moderni – una dualita costitutiva: nel segno della coabitazione e quasi della consustanzialita.
I testi greci, latini e giudaico-cristiani sono affidati all'interpretazione
di Anna Bonaiuto, Gian Carlo Dettori, Maurizio Donadoni, Lino Guanciale,
Sandro Lombardi, Franca Nuti, Galatea Ranzi, Simone Toni; e al commento
di Massimo Cacciari, Ivano Dionigi, Alberto Malliani, Gianfranco Ravasi,
Silvia Vegetti Finzi.
La partecipazione dell’autore-attore Alessandro Bergonzoni sottolinea
le molteplici possibilità del dialogo tra antico e presente.
I testi scelti coprono un arco temporale di oltre dieci secoli. Accanto
a filosofi (EMPEDOCLE, V sec. a.C; PLATONE, V-IV sec. a.C.; EPICURO, IV-III
sec. a.C.; MARCO AURELIO, II sec. d.C.), a poeti greci (OMERO, VIII sec.
a.C.; MIMNERMO, VII sec. a.C.; PINDARO, VI-V sec. a.C.; SOFOCLE, V sec.
a.C.; EURIPIDE, V sec. a.C.; LEONIDA, IV-III sec. a.C.) e latini (CATULLO,
LUCREZIO, VIRGILIO, I sec. a.C.) e ad autori tecnici (PLINIO IL VECCHIO,
I sec. d.C.), spiccano le figure di SENECA (I sec. a.C./I d.C.) e AGOSTINO
(IV-V sec. d.C.), interpreti principi della meditatio mortis.
A completare la lettura, una significativa selezione di passi dall'Antico
e dal Nuovo Testamento.
![]() Consulta l'indice
(formato .jpg)
Consulta l'indice
(formato .jpg)
![]() Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
Leggi
il libro in formato .pdf
oppure scaricalo
(formato .zip)
Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Gianfranco Ravasi, Gustavo Zagrebelsky, Nomos basileus, a cura di Ivano Dionigi, Milano (BUR), 2006, RICERCHE 11.
La legge come norma convenzionale degli uomini o come norma dettata dalla natura; le leggi scritte della città, che Socrate serve fino alla morte, e le leggi "non scritte", superiori e immortali, invocate da Antigone; la tentazione del popolo di ergersi al di sopra della legge in nome di una nuova giustizia; l'apparato delle leggi sacrali soppiantato dal comandamento nuovo delll'amore.
A partire da tali nodi e contrasti, quattro interpreti contemporanei dialogano con i testi greci, latini e giudaico-cristiani, riuniti qui in un'antologia che ripercorre alcuni momenti esemplari della riflessione antica sulla legge, dall'Antico Testamento all'Antigone di Sofocle, dalle XII Tavole a San Paolo, dai Sofisti ai Padri della Chiesa.
Universale e individuale, assoluta e storica, inafferrabile e onnipresente. Così è la legge. Esposta a dilemmi, contraddizioni e paradossi, e soprattutto a una domanda: quale il suo fondamento? O, con le parole di Pindaro: come può la legge essere essere "sovrana" (nomos basileus)?
Edoardo Sanguineti, Teatro antico. Traduzioni e ricordi, a cura di Federico Condello e Claudio Longhi, Milano (BUR), 2006, RICERCHE 12.
A cura del Centro Studi "La permanenza del classico", Bologna (FuoriThema - LibriArena) 2010, RICERCHE 21.
IN PRIMO PIANO